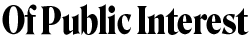Può l' I.A. essere gestita con umanesimo?
Kirghisia è il Paese immaginato da Silvano Agosti[1] dove si lavora tre ore al giorno, dove a 18 anni ogni cittadino riceve una casa, dove i bambini apprendono giocando all’aria aperta e dove nessuno si ammala più, perché gli ospedali servono a poco quando i corpi e gli uomini sono felici.
Ora, immaginate un mondo senza cassieri, senza muratori, senza dottori. Senza idraulici, tassisti, guidatori, cuochi, insegnanti, fotografi, giornalisti. Senza infermieri, sceneggiatori, meccanici, camerieri, impiegati, traduttori. Un mondo di inutili, molti inutili, e l’elenco dei possibili superflui finisce solo dove intelligenza artificiale e robotica non possono arrivare.
In uno studio del 2024 condotto dal FMI[2] si prevede che nei Paesi ad economia avanzata l’IA arriverà ad incidere su quasi il 60% dei posti di lavoro. Negli scenari più estremi una parte di questi posti di lavoro potrebbe completamente scomparire.
Ecco, in questo mondo neanche troppo lontano come si vivrà? Sarà il mondo degli androidi o sarà il mondo di Kirghisia?
Se, come è oggi, l’uomo e il suo lavoro continueranno ad essere pensati sostanzialmente come merce, allora non ci sono buone notizie. Povertà, disordini e guerre sembrano possibili. L’IA verosimilmente peggiorerà la complessiva disuguaglianza economica, aggravando le già preoccupanti differenze tra le diverse fasce di reddito della popolazione globale.
Alle migrazioni climatiche potranno sommarsi flussi anche importanti di ricollocazione all’interno del mercato globale del lavoro, esacerbando crisi umanitarie e favorendo ulteriori criticità anche per le aree più ricche del pianeta.
Disuguaglianze salariali e squilibri macroeconomici
Il CNEL, in un documento prodotto nel 2024[3], osserva come l’impatto della IA sulle attività̀ lavorative e capacità esistenti sia già visibile in diversi settori dell’economia. Processi di automazione (sostituzione del lavoro umano) e task complementarity (affiancamento alle mansioni umane) stanno già modificando la struttura del mercato del lavoro e dei sistemi di produzione di beni e servizi.
Nuove attività̀ lavorative e nuove capacità verranno certamente favorite, ma l’impatto della IA dimostra già le sue criticità. Studi e proiezioni concordano sul fatto che l’impiego significativo di IA generativa induce un processo distributivo asimmetrico tra i gruppi sociali, in particolare a sfavore dei salari.
Si avrà anzi un’espansione del divario tra redditi di capitale e redditi da lavoro. Le conseguenze sono ancora incerte, ma non si può escludere che diminuzione di potere di acquisto e aumento di disoccupazione legati alla riorganizzazione delle catene globali della produzione possano aprire margini per possibili squilibri macroeconomici del rapporto tra produzione di beni e consumi, con relativi fenomeni inflattivi e possibili tensioni economiche da sovrapproduzione.
L’impatto sul welfare
Sul mondo del welfare, alle molte prospettive di rafforzamento, innovazione e sburocratizzazione dei servizi sociosanitari, si affiancano altrettanti problemi[4]. La probabile riduzione della generale capacità contributiva del lavoro ai sistemi di sanità e prevenzione sociale pongono già futuri problemi di consistenza finanziaria.
L’ONU già metteva in guardia nel 2019[5] sui pericoli di una “distopia da welfare digitale” e nel marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato l’AI Act[6], che classifica “ad alto rischio” le applicazioni AI ai servizi pubblici essenziali, tra cui quelli sociali e sanitari. Il rischio è quello di errori e discriminazioni commessi dalle istituzioni con sistemi automatizzati.
Nella progettazione dei modelli AI, bias (distorsione cognitiva che in psicologia indica una tendenza a creare la propria realtà soggettiva sulla base dell’interpretazione delle informazioni in possesso, con possibili rischi di valutazione o di mancanza di oggettività di giudizio) o pregiudizi umani possono riflettersi e rafforzarsi nei dati con cui gli algoritmi imparano a fare scelte e previsioni.
Esistono già casi eclatanti: nei Paesi Bassi[7], un algoritmo governativo ha accusato migliaia di persone di frodare le autorità fiscali, e in particolare le minoranze etniche di truffe legate ai sussidi per minori; caso simile è avvenuto in Australia, con il sistema Robodept[8]. In più, vincolare l’accesso di servizi sociosanitari alle tecnologie può diventare un ostacolo per chi non ha dispositivi e competenze digitali adeguate. Il digital divide (divario digitale determinato dalle diverse possibilità di accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione che penalizza chi ne è escluso in modo parziale o totale) già evidente nelle nostre società, con l’implementazione massiccia della AI nei sistemi di welfare può facilmente allargarsi ad un social divide.
Esiste poi un possibile rischio di deumanizzazione dei servizi di cura, nel senso di perdita del rapporto umano tra operatore e utente. Questo può essere particolarmente evidente nell’assistenza domiciliare o nella telemedicina, ma in generale sono forti i pericoli di impoverimento delle relazioni umane tra operatori e cittadini che usano i servizi sociali e sanitari. A questi, si aggiungono fondate preoccupazioni su possibili fenomeni di marginalizzazione della dimensione pubblica rispetto agli interessi economici dei privati coinvolti nel know-how e nella fornitura di tecnologie.
La natura di utilità sociale del welfare state rischia di perdere rilievo in favore degli interessi delle aziende che vendono alle istituzioni i servizi di AI. D’altra parte, l’aumento esponenziale della potenza computazionale e gli sviluppi della GenAI hanno già portato alla crescente concentrazione di potere in un numero ristretto di global player Usa (Google, Apple, Facebook, Amazon, GAFAM) e tre cinesi (Baidu, Alibaba, Tencent). Queste big sono già proprietari di potenti infrastrutture computazionali, e crescenti volumi di dati sono già impiegati per i test di addestramento dell’IA e lo sviluppo di modelli di rappresentazione individuale e collettiva di consumatori e processi sociali.
Ma l’intelligenza artificiale, se gestita con umanesimo, può anche indicarci la via per Kirghisia e liberare l’uomo dal lavoro non necessario. Questa è la sfida dei nostri tempi e dalle scelte che si faranno dipenderà il nostro modo di stare al mondo.
Articolo di Davide Esposito
Illustrazione di Michele Palumbo
[1] Silvano Agosti, Lettere da Kirghisia, L’Immagine Edizioni, 2004.
[2] Rapporto del FMI sulle conseguenze dell’IA sull’occupazione e sull’economia globale, messo a punto in vista del Forum economico mondiale tenutosi a Davos il 15 gennaio 2024.
[3] https://static.cnel.it/documenti/2024/b888d424-4f5f-48c9-8f08-08cd422d7630/NR%207%20CNEL_%20CASI%20E%20MATERIALI%20L’impatto%20dell’Intelligenza%20Artificiale%20sul%20mercato%20del%20lavoro%20%20nella%20prospettiva%20di%20economic%20complexity.pdf
[4] https://teseo.unitn.it/biolaw/article/download/1347/1349/4328
[5] https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a74493-digital-welfare-states-and-human-rights-report-special-rapporteur#:~:text=Summary,into%20a%20digital%20welfare%20dystopia.
[6] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf.
[7] Welfare e tecnologia: il lato oscuro della digitalizzazione.