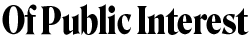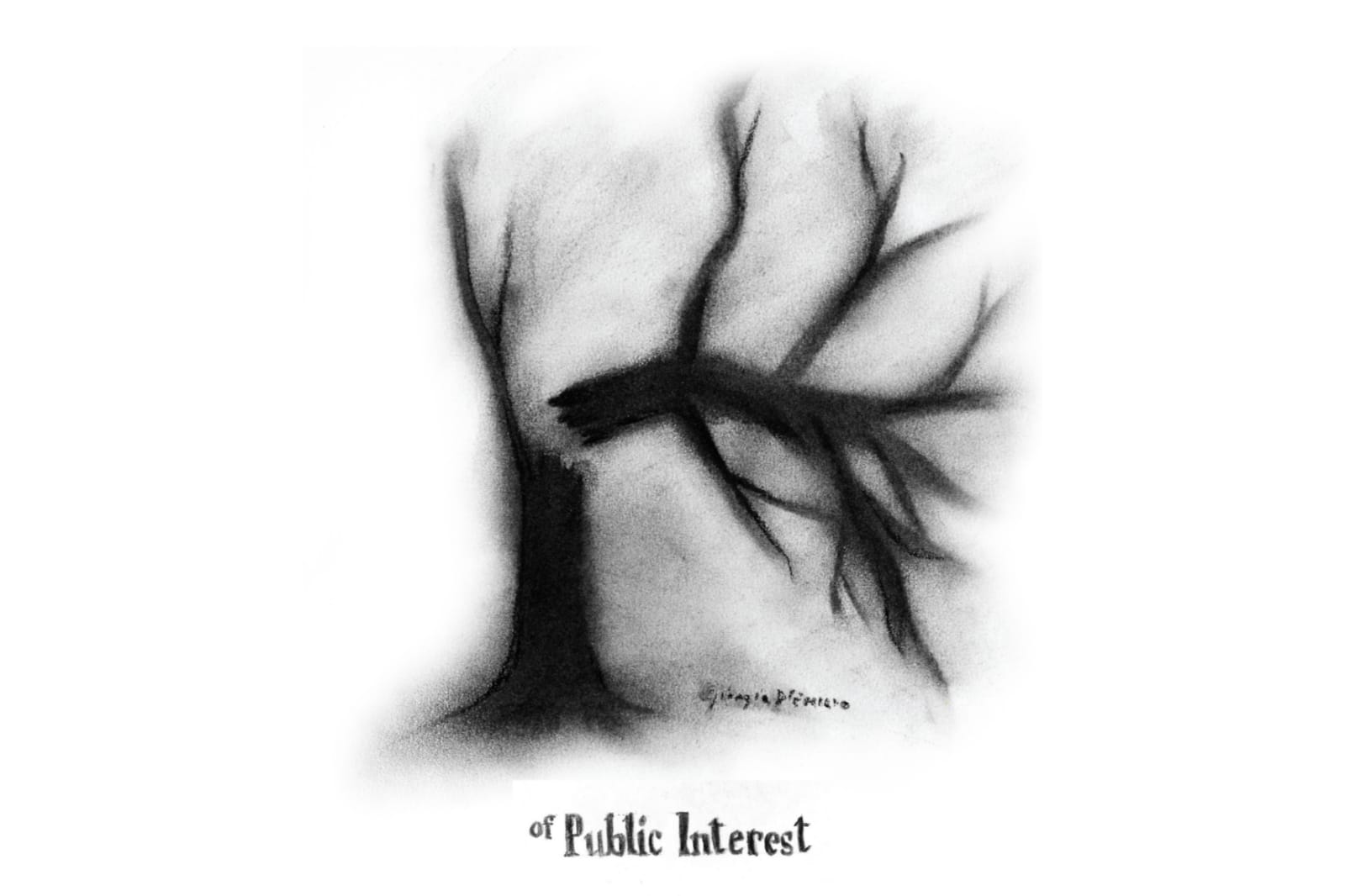L’altro giorno leggevo su una rivista che la produttività e la preparazione media dei lavoratori di oggi rispetto agli anni sessanta è aumentata in maniera esponenziale, ma noi guadagniamo nettamente di meno. Poco dopo mi è capitato tra le mani un libro che parlava del picco di ansia e depressione nei più giovani nell’ultimo decennio. Un fenomeno sociale, che noi trattiamo come un fallimento individuale. Ho dovuto fare un lungo percorso per smettere di sentire sulle mie spalle il peso di un mercato ingiusto.
Ho cominciato presto a preoccuparmi del mondo del lavoro. Forse sono stata precoce, non saprei dirlo, ma a sedici anni, mentre crescevo a Napoli ed ero circondata dalla precarietà, mi sembrava una questione prioritaria. Non avevo la minima idea di cosa fosse il mercato del lavoro, ma un pensiero mi ossessionava: c’ero io, adolescente, nel punto A e volevo raggiungere l’indipendenza, nel punto B. Il tragitto era ignoto.
Investii diverso tempo negli open day, nella speranza di ottenere più strumenti per decidere, ma mi sembrò presto un’operazione di marketing. Ogni polo diceva “scegli me”. Io avevo poche certezze: volevo continuare a studiare e dovevo lasciare Napoli. Se fossi rimasta qui, mi sarei sentita ferma.
Scelsi di studiare Lingue e di trasferirmi in un’altra città al Nord Italia. Mi sentivo pronta a percorrere il mio tragitto. Ma non ebbi nemmeno il tempo di comunicarlo che iniziò una sorta di propaganda da parte di parenti, professori, amici di famiglia per farmi cambiare idea: “Con le tue capacità potresti fare tutt’altro / Non sprecare la tua intelligenza / Perché non pensi ad architettura?”
Ma chi aveva mai pensato di studiare architettura? Critiche senza costruzione e senza motivazione. E mentre io, a diciotto anni provavo a tenermi salda sulle mie scelte, anche il mondo esterno sembra rinfacciarmi continuamente che avevo scelto una laurea di “serie B”. Una volta lessi che il mio corso di studi rientrava nella classifica delle “Lauree inutile”, questo era il titolo su un quotidiano di portata nazionale. Fu ancora più doloroso negli anni a seguire quando si trattò dei professori, coloro che avrebbero dovuto rappresentare l’università. Ricordo le parole di uno in particolare “Non siete qui per trovare lavoro, non lo troverete mai con questi studi al massimo potrete elevarvi umanamente.“
Vivevo nella convinzione di aver capitalizzato male il mio tempo. Selezionai gli esami più difficili, quelli frequentati da massimo cinque, sei studenti. Per un periodo provai con il corso in russo. Volevo a tutti i costi distinguermi, rimediare a quella scelta mediocre che avevo fatto. Quando optai per l’inglese, la lingua che mi appassionava in assoluto di più, lessi la delusione negli occhi della mia famiglia. Avevo ulteriormente declassato il mio percorso.
Un confronto avvilente quello con mia madre e mio padre, appartenenti ad una generazione completamente diversa, quando vent’anni negli anni 80 con una laurea magistrale avevi il mondo in tasca. Un confronto che trovavo spesso anche sterile su un mondo del lavoro per loro oscuro dato che spesso per me che ci sono dentro è incomprensibile.
L’angoscia raggiunse dei picchi di dolore, il dolore si trasformò in sofferenza. Un malessere subdolo, spropositato e persistente, che mi spezzava in due. C’era una distanza di sopravvivenza tra la parte di me che studiava e la parte di me che viveva ovattata dal senso di colpa.
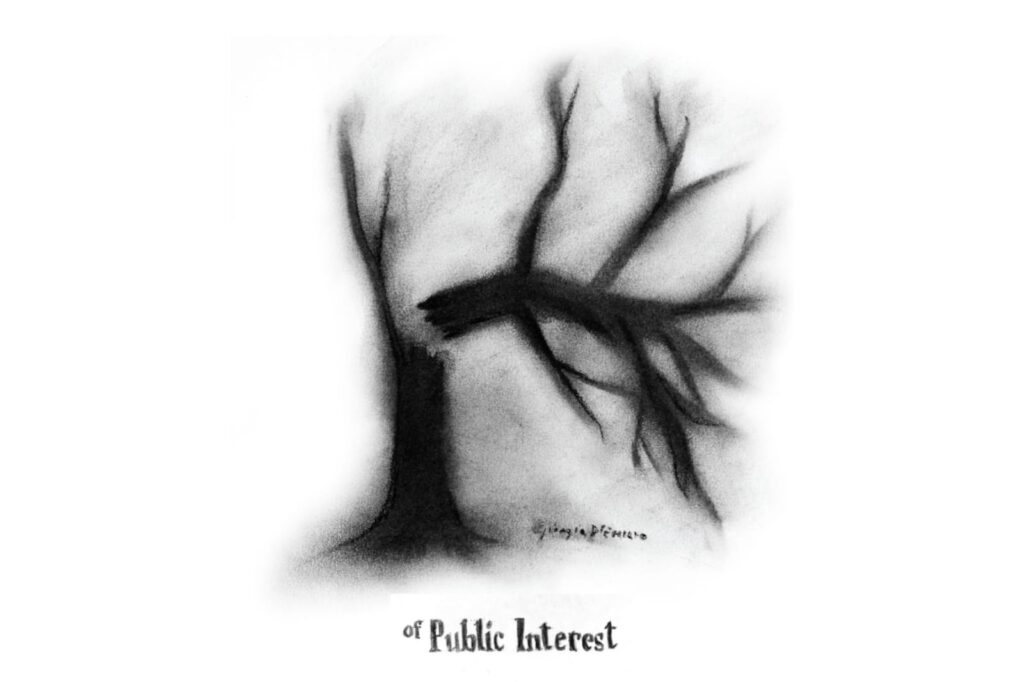
Mi resi conto di quanto fosse grave la mia situazione da un questionario che il rettore dell’epoca ci somministrò. Misurava il benessere mentale in relazione all’università. Una domanda in particolare mi rimase impressa: “Hai mai considerato l’autolesionismo?” Ricordo di aver guardato lo schermo del computer e aver pensato “Sì”.
Sono stata così fino alla laurea. Ogni volta che andavo a dormire mi ripiombava addosso quell’angoscia e aspettavo le sei del mattino per cedere al sonno. Mi rivolsi anche ad uno sportello di ascolto, mi concessero tre sedute, poi mi dissero che non ero a rischio suicidio e che avevano altre urgenze.
Ancora oggi non so dire esattamente cosa mi abbia salvato, se l’amore per mio fratello minore, il lavoro che mi è piombato dal cielo o l’ idea che se avessi ceduto ad un gesto così drastico, avrei passato il mio problema a qualcun altro senza risolverlo.
Oggi lavoro all’estero, mi occupo di un settore abbastanza creativo, che mi soddisfa e che non ho conosciuto tramite l’università, che era completamente scollegata dal mondo del lavoro. Ho trovato subito lavoro, sono stata fortunata. In media, per entrare in un’azienda ci vogliono almeno cinque colloqui.
A diciott’anni non avevo idea che il mercato del lavoro fosse così, a diciott’anni il modello del lavoratore ideale che promuoveva la mia famiglia era datato, vetusto. A diciott’anni mi sembra ci sia tutto il tempo per fare una scelta senza sovraccaricarsi di responsabilità.
Invece fuori mi sembra che ci sia un mondo poco tollerante e senza reti di sicurezza rispetto alle generazioni precedenti. Bisogna essere eccellenti per garantirsi un posto in graduatoria. E mentre s’insegue la tabella di marcia dell’eccezionalità, dentro capita, com’è successo a me, di essere divorati dal senso di colpa, di inadeguatezza, dalla frustrazione dell’incertezza.
L’esperienza universitaria, una volta conclusasi, mi ha lasciato uno strascico a lungo termine. Per anni ho sentito il bisogno di dover dimostrare qualcosa e sono stata per molto tempo una lavoratrice facilmente sfruttabile. Sentendomi fortunata o privilegiata ho accettato qualsiasi straordinario per senso del dovere e ho impiegato molto tempo prima di sviluppare un rapporto bilanciato con la mia carriera.
Che io sia stata determinata, che io ce l’abbia fatta o meno, poco conta rispetto a tutto il dolore che ho provato.