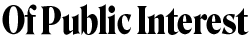Ho fatto un viaggio, ne ho fatto più di uno. Ho fatto lo stesso diverse volte, in realtà. La mia è solo una storia che si ripete.
Ho lasciato la mia terra a sedici anni, ero curioso come un bambino di scoprire come fosse il mondo e all’epoca, forse, ero ancora un bambino. Ma avevo le idee molto chiare. Volevo vivere una vita da uomo libero, senza dovermi dichiarare credente non avendo credi, senza correre il rischio di dover combattere una guerra che non fosse la mia, potendo rientrare ogni giorno a casa senza la paura di esplodere in aria. Per non snaturarmi, avevo una possibilità: partire.
Era dentro di me quest’idea positiva dell’Europa, un continente dove vigeva il rispetto dei diritti umani, e spinto da questa prospettiva mi sono detto: se resto qui, sarò un uomo infelice per il resto dei miei giorni e vivrò comunque nella paura di morire. Se parto, quasi sicuramente rischierò la vita. Cinquanta e cinquanta, insomma. Ho scelto il rischio.
Sono partito senza documenti, ho attraversato a piedi i confini passando tra le montagne, sono arrivato in Turchia e sono stato affidato al mio destino su un gommone. Il trafficante ti accompagna nel punto di partenza, per il resto te la devi vedere tu. Tu e i tuoi compagni. Il viaggio avviene sempre di notte, si approfitta del buio. Dopo ore in mare abbiamo toccato le coste di un’isola greca e siamo scesi a terra. Non avevamo idea di dove fossimo, né sapevamo che direzione prendere. Io ho visto una stella cadente e ho convinto i miei compagni a seguirmi. Siamo arrivati in una città all’alba, ci siamo arrivati guidati letteralmente dalle stelle cadenti. Una volta giunti al porto, in cerca di un traghetto, la polizia locale ci ha arrestati. Ci hanno spogliati e deprivati di tutti i nostri averi e poi ci hanno lasciato per ore in una stanza. Appena ci ho messo piede, ho notato subito un gommone contro la parete.
Ci hanno picchiati, poi siamo saliti su un motoscafo qualche ora dopo. Una volta in alto mare, hanno lanciato prima il gommone, avendo la cura di bucarne le camere d’aria, poi hanno buttato noi. Della serie: vivi o morti, fa lo stesso. Nel gommone entrava acqua, abbiamo provato a chiedere aiuto ma non c’era nessuno. Eravamo dei ragazzini. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto: qualcuno remava con le mani, gli altri buttavano via l’acqua che si accumulava nel gommone.
Ho visto la morte, sì. L’ho toccata con mano. Ma ero pieno di adrenalina e non realizzavo nemmeno il terrore che stavo provando. Dopo poco siamo approdati su un pezzo di terra, ma non era terra ferma, solo una lingua di isola in mezzo al mare. Il gommone era pieno di acqua. Ci siamo fermati. Abbiamo acceso un fuoco nella speranza che arrivasse la guardia costiera. Poi ci siamo addormentati, ricordo di essere caduto in un sonno profondo, non dormivo da più di quaranta ore. Mi sono risvegliato circondato da fucili. Siamo rimasti in una caserma turca per dieci giorni, poi ci hanno rimpatriati. Ho dovuto chiedere a mia madre i soldi necessari per ripartire, altrimenti sarei marcito lì.
Per mesi ho allontanato l’idea di ricominciare il viaggio. Non ne avevo le forze, soprattutto dopo aver toccato con mano che cosa potesse significare morire in mare. Avevo rischiato la vita per un’idea, per un’Europa solidale, ero stato gettato in acqua come spazzatura. Negli anni mi sono chiesto se quegli uomini avessero figli, che cosa avessero provato una volta tornati a casa all’idea di aver gettato otto ragazzini in acqua. Se avessero chiuso gli occhi una volta nei loro letti.

Mi sono deciso mesi dopo, avevo trovato un lavoro e degli amici intenzionati a partire. Stesso percorso, la traversata dei confini di notte, le pause, i trafficanti, i villaggi, i rifugi. Poi macchine, passaporti falsi, altri trafficanti. Ancora il mare, il gommone, i remi. Ancora la polizia che ci butta in acqua.
E poi la terra ferma, di nuovo in Turchia. Lì siamo stati ingannati: durante il percorso in strada uno dei nostri compagni si era sentito male ed eravamo stati costretti a fermarci, a chiedere acqua bussando alle porte delle case lungo il nostro tragitto. Ci ha accolto una donna, una persona gentile, ci ha offerto dell’acqua e ci ha trattenuti dicendoci che ci avrebbe preparato una colazione tipica del luogo.
Poco dopo é arrivata la polizia e siamo finiti di nuovo in una caserma, in mezzo ad un bosco. Mangiavamo una volta al giorno e si trattava di avanzi. Arrivati al terzo giorno non ci hanno portato nulla. Non abbiamo resistito, la rabbia è esplosa e sono partite le rivolte. Abbiamo tirato calci ad una porta, colpo dopo colpo ci siamo resi conto che si era rotta la saldatura.
In quel momento è nata l’idea della fuga, l’abbiamo pianificata giorno dopo giorno, nell’ora d’aria. È avvenuta qualche sera dopo, quando la guardia di turno si è recata in bagno e noi siamo scappati. Abbiamo rotto il resto del catenaccio, scavalcato il muro e cominciato a correre. Abbiamo corso per ore nel bosco, nel nulla. Siamo scappati solo in otto, gli altri pensavano che sarebbe stato un suicidio. Io mi sono ritrovato di nuovo di fronte alla scelta: picchiato, ammazzato, rimpatriato oppure, ancora una volta, il tentativo di essere libero.
Siamo rimasti quarantotto ore nel bosco, senza bere, senza mangiare. Poi siamo arrivati a casa di un trafficante ed è arrivato il terzo tentativo in mare. L’ultimo. Toccata la terra ferma, siamo riusciti a raggiungere la Croazia. Ci siamo infilati su un camion container, traghettato su una nave. Dopo ventotto ore ero in Italia.
Nel container si entra di nascosto, il conducente non deve accorgersi di nulla. Noi in quelle ore non ci siamo mai mossi per non destare sospetto. Poi di nuovo un dilemma, di nuovo la necessità di scegliere. Eravamo appena usciti dal porto e ci trovavamo in un’aerea di servizio, il camion era fermo. Uno dei nostri compagni non riusciva a respirare. Il trafficante ci aveva raccomandato di non chiamare per nessuna ragione il conducente, ma il ragazzo stava morendo. Era dura, si erano create due fazioni. Se da una parte rischiavamo di essere riportati ancora una volta indietro, di aver combattuto per la nostra libertà a vuoto, dall’altro c’era la vita di una persona.
Alla fine abbiamo ragionato così: se bussiamo, scappiamo e ci salviamo, oppure scappiamo e ci prendono. Però saremo vivi, forse rimpatriati. Ma vivi. Ma se non agiamo, il ragazzo muore sicuramente e da questo si non torna più indietro. Erano tutti convinti.
L’autista era sotto shock, non aveva minimamente sospettato della nostra presenza. Lo abbiamo sentito chiamare la polizia. In pochi minuti siamo scappati. Ricordo che ci siamo seduti sotto un albero e ci siamo riposati.
I poliziotti sono arrivati dopo poco. Ci hanno puntato le pistole alle tempie, ma ho sentito subito che l’approccio era diverso. Siamo stati curati, trattati con tranquillità, abbiamo chiesto dell’acqua ce l’hanno data, ci hanno anche insegnato a dire acqua in italiano. Qualche abitante del paesino ci ha portato biscotti, torte, bevande e altro. Si era creata una fila di persone pronte ad aiutarci.
Sono passati tredici anni dal giorno in cui sono stato portato in comunità. Oggi vivo la mia vita in Italia, la vivo come desidero e lavoro con i rifugiati.