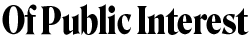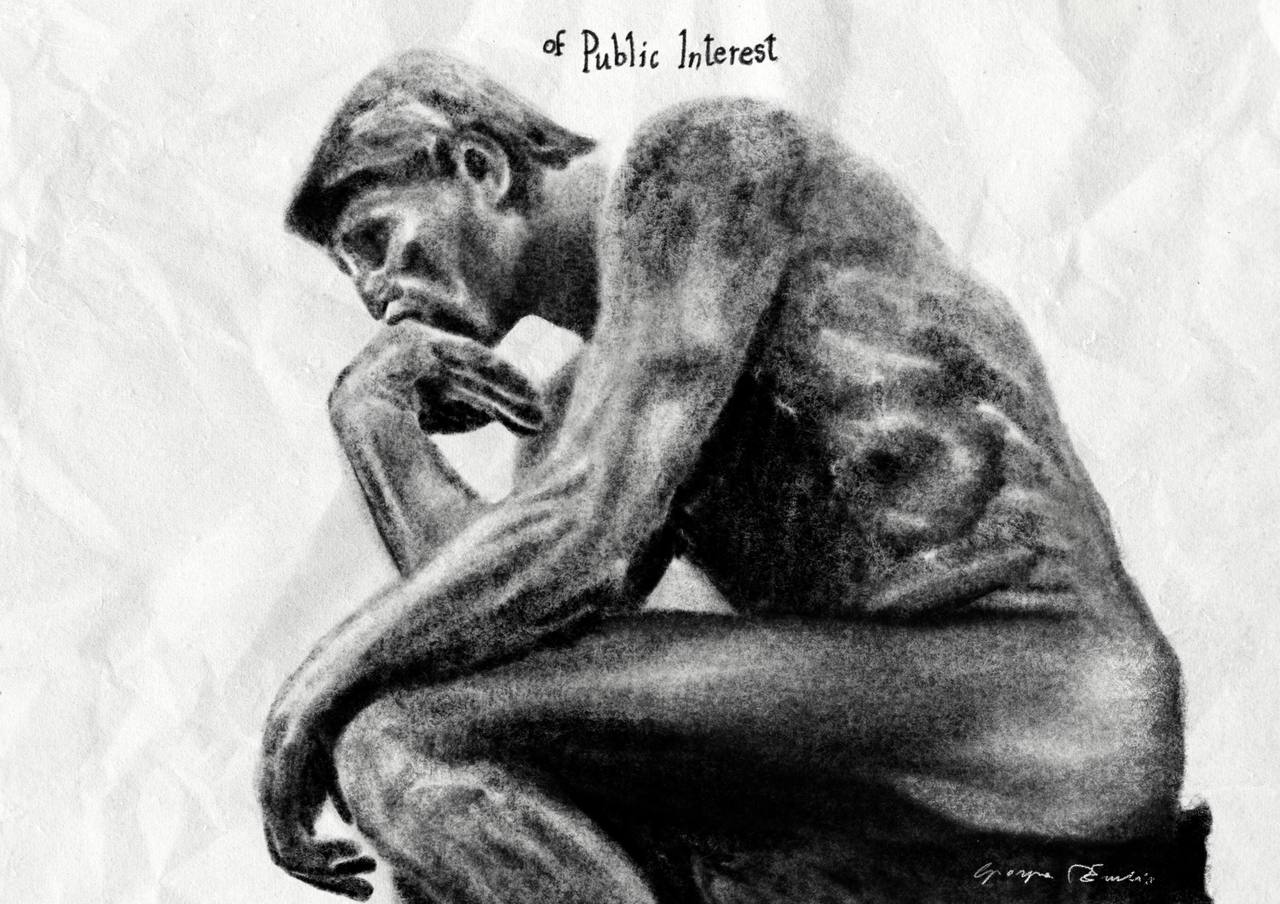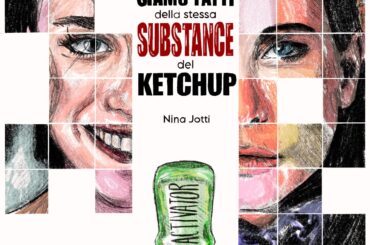La classe dell’asilo era un po’ grigia, un po’ verde, alcuni tavoli rotondi altri a forma di rombo. Due finestre, una mezza libreria, la scrivania vicino la porta, la lavagna dietro, il Crocifisso con una palma inficcata tra le scapole frustate, un orologio bianco.
Il cibo della refezione arrivava su un carrello, lo stesso che veniva distribuito in ospedale: arrivava in pacchi di polistirolo scadente, un fetore osceno fuoriusciva non appena s’apriva il coperchio. Merluzzo sciapito che nuotava nella sua stessa acqua di cottura, prosciutto crudo gelatinato nella plastica, mozzarella gommosa anch’essa galleggiante nel suo siero acidulo. Quello che ricordo con maggiore disgusto era il sartù di riso; ancora oggi fatico a mangiare riso sugo e piselli nello stesso piatto. Non è stato difficile diventare fan dei piatti di mia nonna e mia madre. Una volta ci lasciarono senza cibo. Ci accorparono ad un’altra classe, alcuni di noi si misero sotto al tavolo.
Nei bagni delle bimbe cercavamo di ricordarci bene i passi della canzone Cicale di Heather Parisi.
Non era tutto così grigio: la maestra Ersilia era dolce e trasmetteva quell’aria di torta appena sfornata. Una volta le rovesciai tutto il caffè che mi aveva chiesto di portarle sulla camicia: era di seta, color panna, aveva una collana di perle. Lei scoppiò a ridere, mi fece una carezza, disse che non era successo niente.
C’era un lungo corridoio e poi una palestra, larga, dove correvamo sempre in cerchio. Nella palestra un’altra piccola stanza, a mo’ di sgabuzzino, con tanti tappetini di gomma. Davanti la porta della palestra, seduta sulle seggioline per noi bimbi, la maestra Donata. Aveva gli occhiali tondi e lo sguardo assente, capelli castani che le arrivavano giusto sotto l’orecchio. Era sempre seduta nella posizione del Pensatore di Rodin, più o meno: gambe incrociate, gomiti sulle ginocchia, la testa appoggiata sul palmo della mano. Noi correvamo, e lei stava lì a pensare.
Mi ritrovai una volta nello stanzino dei tappetini di gomma con due bimbi, alla sola luce fioca del vetro della porta chiusa. Come ci arrivai, non ne ho memoria. Uno dei due si spogliò, l’altro guardava attento. Mi chiese di toccargli il pisellino, riluttante, lo feci. Poi mi chiese di spogliarmi; il ricordo è sfocato, voglio credere di aver detto di no, ma i miei pantaloni si abbassarono comunque, mi toccarono la patatina. Solo la superficie, non andarono dentro. Una volta soddisfatti dell’ispezione, i bimbi se ne andarono e ritornarono nel cerchio. Riferì alla maestra Donata l’accaduto, ma più di un cenno di assenso, da lei non ebbi altra risposta.
Quando lo dissi a mio padre, gli portai una Barbie per spiegargli com’era avvenuto il fatto. La spogliai dei jeans a zampa di elefante e gli indicai la patatina inesistente, e giurai che più in là non si erano spinti: mi sentivo chiaramente in colpa, questo lo ricordo bene. Lui mi rispose con un trattenuto “va bene”, un’espressione che mi giurava vendetta. Il giorno dopo disse ad uno dei bimbi che se l’avesse fatto di nuovo, gli avrebbe spezzato il braccino. Neanche mia mamma sa che fu detto alla maestra Donata, qualche tempo dopo questa chiese il trasferimento e tranne per quell’episodio, non ricordo più niente di lei, ma solo il profumo di torta della maestra Ersilia.
Mi fu poi spiegato dallo psichiatra che l’accaduto in sé, anche se violento, anche se mi ha lasciato degli in sospeso, faceva parte della voglia di scoperta di un bimbo. Nella sua crudezza, era naturale. L’assenza della maestra, quello no, non lo era.
Ho una laurea magistrale, ma l’unico lavoro che al momento ho trovato, è all’asilo. Credo che al giorno d’oggi le cose funzionino così: quando non hai nessun titolo e una minima idea per affrontare quello che stai andando a fare allora ti assumono. Se hai un titolo e hai sudato per guadagnartelo, puoi tranquillamente cambiare i pannolini. E mentre, giorno dopo giorno, ho a che fare con decine di bambini, vivo con perenni sensi di colpa, l’uno incastrato nell’altro.
Un lunedì entro in classe a metà mattinata, la mia collega M. cerca di controllare, come dal primo giorno, una situazione caotica ed insostenibile. Mi accorgo di un oggetto di metallo che rotola per terra, senza pensarci lo prendo e lo metto nel marsupio, corro poi a sostenere M. Due giorni dopo, parlando con N. del personale A.T.A. di quali oggetti pericolosi in classe togliere, ricordo di quello rotolante di metallo, glielo faccio vedere. Mi guarda sorpresa. Questo è un proiettile, non lo hai riconosciuto? No, non ne ho mai visto uno prima. Scintillante, pesante e con la polvere da sparo ancora attorno, mi ha spiegato il poliziotto che ha raccolto la mia dichiarazione. Se non sono nanetti e pupazzetti, qualsiasi oggetto diverso deve essere immediatamente denunciato, mi ha strigliato il direttore dell’edificio.
Come hai fatto a non accorgertene, mi hanno chiesto.
Troppi bambini e poche maestre, poche aule e troppo piccole, siamo isolate: prima che ci vengano ad aiutare per portare un bimbo in bagno, a volte questo si è già fatto addosso e mi guarda perso, come a dirmi “ho commesso qualcosa di grave?”. Ed io subito mi affretto a dirgli di no. Non è grave.
A volte, per la frustrazione, mi ritrovo a prenderli per il braccio, a dirgli con voce dura di smetterla di fare quella cosa perché mi stanno esaurendo e li metto seduti su una sedia. Me ne pento subito. Mentre li addormento mi ritrovo ad accarezzarli e ad intonare forte la ninna nanna come a chiedergli scusa:
Chi mi ha insegnato a nuotar?
Fu un marinaio? Furono i pesci del mar?
Avrei dovuto rispondere questo al “come hai fatto a non accorgertene?”
Questo mestiere ha bisogno di una vocazione, che io non ho. Mi dico che mi ci sono ritrovata a farlo perché ora non ho altre possibilità, perché la scuola disperata ha bisogno di qualunque disperato sia disposto. Ma non so se è così. Sono costantemente sola tra maestre che credono e lottano per quello che fanno, che si sentono altrettanto sole. Sono così presa dalla mia frustrazione, che non mi sono accorta che quella che avevo nel marsupio era una pallottola. E mi chiedo, sto ignorando anche io loro come fece con me la maestra Donata? Anche io mi perdo nella posizione del Pensatore? E se avessero tirato a me il braccio per farmi sedere su una sedia? Cosa avrei pensato di quella maestra, cosa pensano i bambini di me? La maestra Donata mi avrà chiesto scusa a modo suo?
Il giorno del proiettile, di ritorno a casa mi sono scoperta inquinata: dal suono delle ambulanze, delle volanti e del traffico, delle urla sguaiate. Dalla puzza di piscio, spazzatura e animali morti. Dalla calca, dalle strade rotte, dalle cacate di piccione, dal cibo buttato. Un mio caro amico, M. mi ha detto, col sorriso sulle labbra, he’ fa’ pace c’ ‘o pensiero.
Ma qualcosa non va se vivi in un sistema che non ti fa crescere serena, vero? Qualcosa non va se in una città, dove c’è tanto male, soffochi ogni giorno dall’idea che forse, rischi di fare di peggio.
He’ fa’ pace c’ ‘o pensiero.
E se non volessi, truva’ pace?