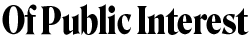Il 29 dicembre 2023 il Sudafrica ha citato Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia con l’accusa di genocidio. In un processo storico al tribunale dell’Aia, la cui giurisdizione è la Convenzione sul Genocidio, il Sudafrica del post-apartheid cita Israele, uno stato che, ad oggi, è retto da un regime di apartheid.
Non è semplice accertare che il massacro di un gran numero di persone, in guerra o in tempo di pace, sia un caso di genocidio. Infatti, uno dei criteri principali è quello dell’intenzione, esplicita o implicita, a sterminare un intero gruppo etnico. Del resto, non è ancora mai successo che un genocidio fosse riconosciuto come tale mentre stava succedendo. Anzi ci sono genocidi che ancora oggi non sono riconosciuti né dal tribunale dell’Aia, né dalla storia.
Un momento storico
Qualsiasi il risultato finale, l’istituzione stessa di tale processo è un momento storico che evidenzia una serie di cambiamenti a livello internazionale.
Nella prima fase del processo, iniziata 11 e 12 di gennaio 2024, il Sudafrica deve limitarsi a dimostrare che l’accusa di genocidio è plausibile. Infatti, anche se il processo potrebbe durare anni, il team legale sudafricano ha richiesto che misure provvisorie siano istituite contro Israele, che includono la cessazione immediata delle attività militari. Purtroppo, posto che nelle prossime settimane la Corte deciderà a favore del Sudafrica, non è detto che le misure provvisorie siano applicate.
L’unico organo internazionale in grado di porre pressione su Israele è il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nel quale già ripetutamente gli Stati Uniti hanno usato il diritto di veto per bloccare qualsiasi iniziativa tesa a rendere Israele responsabile per le sue violazioni del diritto internazionale.
Nonostante questo quadro poco ideale, la decisione del Sudafrica di citare Israele sembra un tentativo di rompere finalmente con il muro di omertà costruito dalle potenze occidentali intorno ai crimini dello Stato di Israele contro il popolo palestinese.
Le posizioni di altri Stati
A pochi giorni dall’inizio del processo, la Germania ha dichiarato che vuole costituirsi come terza parte in tribunale e dare supporto ad Israele nel processo contro l’accusa di genocidio. Inutile dire che, aldilà del legame storico tra Germania e Israele, rispetto all’anno scorso il flusso di armi tedesche esportate in Israele nel 2023 è aumentato di 10 volte.
La Namibia, ex-colonia tedesca, ha prontamente mosso dubbi sulla capacità della Germania di offrire un punto di vista rilevante rispetto a un caso di genocidio, considerato che il primo genocidio del 20esimo secolo fu proprio ad opera tedesca contro le popolazioni Herero e Nama della Namibia. Ad oggi, il governo tedesco si rifiuta di pagare compensazioni ai discendenti delle popolazioni massacrate.
Ciò che il Sudafrica implicitamente cerca di fare con questo processo è ricontestualizzare la questione palestinese in un’ottica di liberazione dei popoli dal colonialismo, vecchio e nuovo, e dall’apartheid.
Ma non era una guerra al terrorismo?
Una prospettiva antitetica rispetto a quella proposta da Israele, che invece inserisce l’attuale conflitto in un’ottica di “guerra al terrorismo globale”. L’ottica della guerra al terrorismo domina la politica estera degli Stati Uniti e dei suoi alleati a partire dagli attentati dell’11 settembre 2001 e ha giustificato, per esempio, l’invasione dell’Iraq nel 2003 (tra cui i crimini commessi dall’esercito americano ad Abu Ghraib) sfruttando un crescente sentimento anti-arabo e islamofobico.
Il fatto che due paesi africani, insieme ad un gruppo molto più ampio di paesi del cosiddetto Sud Globale, si siano schierati così chiaramente dalla parte del popolo palestinese non deve sorprendere. A partire dagli anni ’50 e fino agli anni ‘70 è il momento d’oro delle lotte per la decolonizzazione e l’indipendenza. Moltissimi dei movimenti di liberazione strinsero rapporti stretti, sia politicamente che dal punto di vista militare, tra cui anche il Congresso Nazionale Africano (ANC) di Nelson Mandela e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di Yasser Arafat.
Le conquiste nella lotta al colonialismo
Le relazioni multilaterali tra ex-colonie, basate sul riconoscimento di una storia comune di oppressione e anche di liberazione dal giogo coloniale, portarono al crearsi di una coalizione forte all’interno della neonata società internazionale. Mentre Israele e il Sudafrica dell’apartheid si spalleggiavano a livello internazionale, fu proprio quel tipo di coalizione anticoloniale che riuscì a dare un forte impulso nella lotta al razzismo istituzionale e al colonialismo, ottenendo risultati importanti sia culturalmente che politicamente. Un esempio è la risoluzione dell’Assemblea Generale ONU 37/43 che riafferma “la legittimità della lotta dei popoli per l’indipendenza, l’integrità territoriale, l’unità nazionale e la liberazione dalla dominazione coloniale e dall’occupazione straniera con tutti gli strumenti possibili, inclusa la lotta armata.”
Il Sudafrica raccoglie questa tradizione e rilancia con un nuovo fronte che si oppone apertamente non solo all’apartheid israeliano ma indica gli Stati Uniti e alleati come complici del genocidio. Con i dovuti limiti di questi paralleli storici, l’ANC del post-apartheid oggi ribadisce davanti al mondo intero la necessità di vedere il conflitto israelo-palestinese per quello che è: la lotta di un popolo oppresso contro uno stato coloniale oppressore. Non solo, ma rende onore alla memoria del suo membro più famoso, Nelson Mandela, che ha detto che nessuno sarà libero finché la Palestina non sarà libera.
Quand’è che la Palestina sarà finalmente libera?
La pace non si crea dal nulla, ma si deve costruire. E spesso pace non significa non-violenza.
L’associazione tra la resistenza palestinese e Nelson Mandela può sembrare a molti strano. Pensiamo sempre a Nelson Mandela come a un simbolo della pace, mentre immaginiamo i palestinesi come la rappresentazione di un conflitto eterno. Tuttavia, Mandela negli anni ’90 era considerato un terrorista per aver fondato il braccio armato dell’ANC, che non era certo un movimento non-violento.
Spesso si pensa erroneamente che essere per la pace equivalga a essere contro ogni tipo di violenza. Ma in un contesto di oppressione non è possibile equiparare la risposta violenta dell’oppresso a quella dell’oppressore.
Riporre le armi, come ha invocato Israele venerdì alla Corte Internazionale di Giustizia, non è un’opzione per il movimento di liberazione palestinese, nonostante il massacro in corso. E non perché i palestinesi siano necessariamente terroristi assetati di sangue che usano la popolazione civile come scudo, ma perché, sia che Hamas ceda o che venga effettivamente eradicato da Israele, la situazione del popolo palestinese difficilmente cambierà per il meglio.
Nel contesto di un conflitto tra una potenza nucleare ed un gruppo armato, lasciare le armi significa rinunciare all’unica possibilità che rimane ai palestinesi di uscire dal conflitto vivi, sia fisicamente che come popolo, lasciando il dominio assoluto della violenza in mano allo Stato di Israele.
Guardando il passato ma pensando al futuro.
Dunque pace significa non-violenza?
Nonostante questo, è chiaro che sia da parte palestinese che israeliana esiste un fronte per la pace che utilizza metodi non-violenti. Ovviamente assumono forme diverse da un lato e dall’altro.
Pensiamo per esempio alla Grande Marcia del Ritorno. A partire dal 30 marzo 2018 e per più di due mesi, i palestinesi hanno marciato verso il muro di separazione tra Israele e la Striscia di Gaza, protestando pacificamente contro apartheid, occupazione e per il ritorno dei rifugiati palestinesi alle proprie case. Il risultato? Circa 200 morti e più di 33.000 feriti, secondo il calcolo delle Nazioni Unite.
Dal lato israeliano invece, il fronte per la pace si concentra sulla demilitarizzazione e la ricerca di una soluzione politica. è costituito da diciottenni che si rifiutano di arruolarsi, da veterani che hanno deciso di denunciare l’occupazione, e molte altre realtà che criticano il governo sionista e cercano di costruire un dialogo tra la società israeliana e quella palestinese.
Se c’è una cosa di cui possiamo essere cert*, a giudicare dagli ultimi tre mesi, è che non ci sarà un’uscita militare dal conflitto. Invece, c’è bisogno di un’inversione politica e di prese di responsabilità, nonché di giustizia per riparare ai danni enormi che questo conflitto ha portato alla società palestinese, e anche, in misura diversa, a quella israeliana.
Nel dare un altro impulso al movimento di solidarietà internazionale con il popolo palestinese, il Sudafrica sta contribuendo a costruire a livello internazionale un contesto che renda possibile questo cambiamento e che porti non solo alla pace e alla fine della violenza in tutte le sue forme, ma ad una giusta liberazione per il popolo palestinese.
Illustrazione nel testo a cura di Giorgia D’Emilio