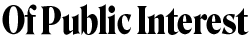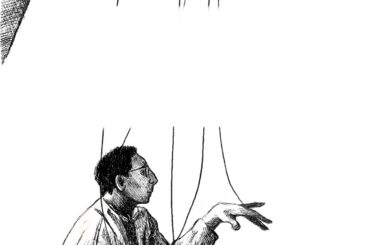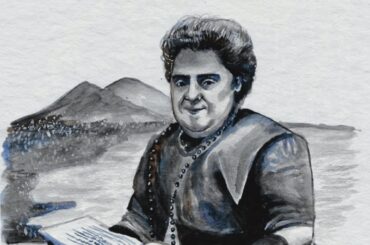Intervista a Paola Russo, medico psichiatra, analista AIPA.
Ho un’immagine nitida nella testa: ad un tavolino di un bar c’è una donna che allatta un bambino. Con il braccio sinistro lo tiene stretto al seno, con l’altro, teso dalla parte opposta, regge il cellulare. Così il volto della madre si perde nello schermo e non si dona allo sguardo del neonato. Un’ immagine emblematica di qualcosa che si è perso, o che forse sta cambiando irreversibilmente: la relazione.

In che modo è cambiata?
Mi torna in mente una citazione di Winnicot, noto psicoanalista inglese: “Quando il lattante guarda il viso della madre di solito ciò che vede è sé stesso”. È questo l’inizio di uno scambio significativo con il mondo, da qui inizia il sano sviluppo psichico dell’individuo. L’uso indiscriminato della tecnologia può distorcere la percezione della realtà, delegare a degli oggetti lo scambio di emozioni, alienare l’individuo dalla sua stessa comunità e soprattutto anche da se stesso. Già vengono segnalati dagli esperti dell’infanzia, nei piccoli bambini, problemi di sviluppo, relazione e funzionamento mentale, verosimilmente ascrivibili alla sovraesposizione a cellulari, tablet e altri dispositivi digitali.
Che ricaduta può avere questa forma di isolamento sulla salute mentale?
Ripenso alla mia esperienza professionale, a partire dall’ospedale psichiatrico di Aversa, nell’unità diretta dal prof. Vittorio Donato Catapano. Lì ho potuto vivere, partecipandovi attivamente, la stagione dei grandi cambiamenti che la psichiatria stava attraversando, culminata con la chiusura dei manicomi sancita dalla legge 180, meglio nota come legge Basaglia. Tutto questo fu reso possibile principalmente mettendo al centro le persone, i ricoverati e i curanti, incrementando relazioni personali e gruppali, piccole rivoluzioni che diedero, in tempi relativamente brevi, risultati inaspettati
Oggi purtroppo c’è la tendenza opposta che svalorizza l’importanza della relazione e si impronta sull’efficienza, sull’ ipervalutazione dei farmaci, su percorsi psicoterapeutici abbreviati che non saldano la relazione, perseguendo unicamente la scomparsa del sintomo che spesso poi riemerge in altra forma. Questo vale anche nella medicina generale dove pure la relazione è molto importante per allargare le possibilità di guarigione, di miglioramento, persino di risposta al farmaco. Dati scientifici suffragano convincentemente la stretta connessione tra benessere fisico, equilibrio emotivo e sane relazioni affettive.
Come si alimenta la capacità di ascolto al di fuori di un ospedale?
Con la comunità. Il gruppo può essere una grande risorsa, dalla famiglia, alla scuola, implementando un metodo educativo basato sul pensiero critico, che insegni a stare in relazione. Bisognerebbe ritrovare la nostra umanità. Magari attingendo alla forte passione civile e politica che circolava negli anni 70, nonostante le sue derive estreme, perché ledinamiche che appartengono all’essere umano non sono mai lineari. Bisogna imparare a riflettere e a dialogare con l’altro, senza idee precostituite, per costruire il bene comune.
Oggi ci sono i presupposti per entrare in forme di relazione più autentica?
Oggi siamo tutti in connessione e molto poco in relazione. Non posso emettere un giudizio di merito, siamo in un processo, in un flusso di continui cambiamenti e da questo punto di vista la tecnologia accelera i processi. Non sappiamo per es. dove ci condurrà l’intelligenza artificiale.Con queste osservazioni, non sto proponendo una sorta di misoneismo, la paura del nuovo, che ci porti a diffidare di tutto quanto rischia di sovvertire, per la propria forza innovatrice, i consueti modi di pensare e le nostre abitudini. Non è mai cattiva la scoperta o l’invenzione in sé, è piuttosto l’uso indiscriminato che noi ne possiamo fare.
Come prevenire i danni delle innovazioni che caratterizzano ogni epoca?
Bisognerebbe trovare sempre il tempo per mettere delle distanze, per fermarsi e per pensare. Ma in quest’atto contro corrente, non si può essere soli.
Il cinema aiuta a riflettere, ad esercitare questa visione critica comune?
La scelta di andare al cinema ci pone in contatto con l’altro, anche solo per il fatto che si possa condividere una reazione con un vicino a fronte di un’immagine proiettata. Diversamente dalla televisione e mezzi affini che quasi impongono la solitudine, l’atto di scendere di casa ed entrare in una sala cinematografica è già una scelta di condivisione. L’interpretazione soggettiva di ciò che appare sullo schermo non sarà solo il prodotto del singolo occhio che guarda, ma essa nasce e appartiene anche al contesto. Benché gli spettatori appaiano isolati l’uno dall’altro nel buio della sala, si crea un campo emozionale condiviso attraverso la valorizzazione dell’immagine. E l’immagine è fondamentale, essa ci permette di fantasticare, di creare un ponte tra l’inconscio e la coscienza, tra noi e gli altri, proponendosi in ogni caso come potenza creatrice. Oggi invece, come sottolinea qualcuno, non siamo nell’epoca dell’immagine ma del visivo, sommersi come siamo da immagini che scorrono velocemente davanti ai nostri occhi, spesso senza che ne possiamo capire il senso e coglierne le risonanze interne.
Un festival di cinema è quindi una palestra di relazione?
Decisamente si. È uno dei luoghi in cui poter esercitare quel pensiero comune, imparando l’ascolto e condividendo le emozioni. Basta pensare ai dialoghi che seguono le proiezioni, alla varietà delle tematiche su cui riflettere, alle sensibilità che possono intersecarsi. Alle relazioni, che possono superare lo stadio superficiale di mere connessioni, e diventare crescita collettiva.
Illustrazione di Giorgia D’Emilio