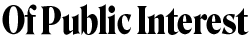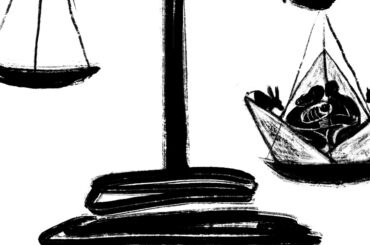Vi siete mai chiesti quale possa essere realmente il potere della bellezza? Io sì e per questo vorrei parlarvi di The Substance, di Coralie Fargeat.
Figlio del suo tempo
Elisabeth (Demi Moore) ha attorno ai sessant’anni, è un’attrice e soprattutto una stella cadente della televisione americana, per la quale ha condotto per anni una trasmissione d’aerobica. Viene poco gentilmente cacciata dal suo stesso programma proprio a causa della sua età. Presa dallo sconforto totale si affida alle proprietà miracolose di una misteriosa sostanza verde, che chiaramente agisce a livello genetico e le permette di vivere a turno due vite diverse: per una settimana riveste i panni (o meglio, la pelle) della giovane e bellissima Sue (Margaret Qualley) e per un’altra settimana deve apparire così com’è.
Dai presupposti il film non attrae per un argomento particolarmente inedito. Il tema della paura dell’invecchiamento è stato affrontato talmente tante volte da diventare un vero e proprio sottogenere del body horror, in particolar modo nella filmografia giapponese. Ma The Substance ha due caratteristiche che lo rendono intelligentemente pensato per il pubblico degli anni ‘20 del duemila; è un’opera perfettamente calata nella sua epoca, non tanto per il tema, ma per come lo racconta.
In primo luogo, non si vedono e non si parla mai dei social network, eppure il film gravita comunque attorno a quel mondo. L’ambientazione è una Los Angeles favolistica e l’epoca è quella contemporanea, anche se sembrano ancora gli anni ‘80 dell’aerobica di Jane Fonda. Nonostante ciò ci sembra di essere totalmente calati nella contemporaneità, perché la regista (con la collaborazione di tutti i reparti, ovviamente) ha costruito una messa in scena che richiama in tutto e per tutto l’estetica estremamente curata e ultra nitida dei social contemporanei. Non ha avuto quindi bisogno di palesarne ulteriormente la presenza, collaborando con l’immaginario dello spettatore moderno, lasciando comunque intatta la dimensione di favola macabra.
La seconda peculiarità invece è un ritorno all’unità propria delle origini letterarie del tema. Quella, per esempio, de Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, nel quale il bene e il male sono due facce della stessa medaglia, due volti dello stesso uomo. Sono proprio queste nobili origini a rendere ancora più originale il cortocircuito che vede prevalere, tra la star decaduta Elisabeth e la nuova e incosciente Sue (le due facce di questa specifica medaglia), un mostro pressoché amorfo dal nome di Elisasue, che rompe l’equilibrio malato e ormai abusato della dicotomia vecchio-nuovo.
Il vero horror è nei dettagli
Tra tutto lo splatter e il gore, rimane nella memoria soprattutto il volto paonazzo del produttore televisivo (Dennis Quaid), espressione di una società dello showbusiness che nasconde qualcosa di disgustoso, sporco, sgraziato e probabilmente maleodorante, alle spalle di tutto ciò che deve luccicare. Un’industria non tanto lontana da quella del socialbusiness. Mi vengono in mente a riguardo le foto del volto incremato e glaciale di Mark Zuckerberg o i primi piani estremamente ravvicinati di Elon Musk. Nel film però tutti i volti inquietano, merito delle inquadrature ravvicinate che rivelano una texture della pelle realistica, ma che non siamo più tanto abituati a veder rappresentare.
Comunque, anche da un punto di vista meno formale, la vera tragicità di The Substance non sta in quell’elemento macabro stomachevole, ma nella facilità con la quale ci si riesce a immaginare la stessa vicenda andare in modo molto diverso. Se Elisabeth fosse riuscita a godersi i sette giorni di maturità, cosí come quelli di svagata giovinezza, forse la sostanza non ci sarebbe sembrata un’invenzione cosí catastrofica. Ma il paradosso del film sta proprio nel fatto che senza il suo masochista e ossessivo complesso estetico Elizabeth non sarebbe mai potuta venire a conoscenza del medicinale. Le viene offerta una possibilità quando, incitata da un complimento di una vecchia conoscenza maschile, decide di provare a vivere la sua età. Si prepara di tutto punto ma non riesce a combattere il confronto con quella che non è più e che ora, grazie alla sostanza, potrebbe essere di nuovo. La sua immagine è riflessa nel pomello deformante della porta, simbolo di un mondo esterno pieno di possibilità alle quali lei non riesce a partecipare. Agli occhi di una società dello spettacolo basata sulle immagini, una donna al di sopra dei quarant’anni equivale alla personificazione di una bestemmia, ma nel mondo vero invecchiare non dovrebbe voler dire anche essere svincolata da quelle catene che ti relegano a uno standard di bellezza irraggiungibile?
La protagonista di questo film non è mai libera, entrambe le facce della medaglia sono soggiogate dalle stesse oppressioni, semplicemente in modo diverso. All’apparenza la bianca e ricca, ma soprattutto giovane Sue gioca un ruolo da antagonista. Ma è realmente così? Quale giovane donna vorrebbe invecchiare se vede già chiaramente che ciò che l’aspetta è un completo stato d’abbandono? Elisabeth finisce a odiare Sue visceralmente, ma è in realtà lei stessa ad aver creato i presupposti per cui essere detestata. Questo film si dimostra ancora una volta figlio del suo tempo parlandoci di tutte le Sue del mondo, cioè donne giovani e impaurite che cercano di porre rimedio a un invecchiamento che in realtà biologicamente è ancora molto lontano dall’avvenire.
Le eccezionali attrici scelte hanno la qualità polivalente di essere allo stesso tempo loro stesse e i loro personaggi. Demi Moore torna sul grande schermo, che l’ha vista brillare soprattutto negli anni della sua giovinezza, aggiungendo al suo personaggio tutte le dimensioni della sua carriera e il poster ringiovanito mostrato nel film fa inevitabilmente pensare alla locandina del film Striptease, che la rappresenta nuda e volitiva. Margaret Qualley invece, in quanto figlia nella vita reale dell’attrice Andie MacDowell, ci sembra già essere sin dall’inizio la versione più recente di qualcuno che è già esistito e che abbiamo già visto.
La superficie e la sostanza
Nei giorni immediatamente successivi all’uscita nelle sale è già emersa l’opinione abbastanza diffusa che si tratti di un film diverso per le spettatrici, rispetto a quello che appare allo spettatore. Indubbiamente, come ha raccontato la regista stessa in varie interviste, lo sguardo rivolto alle donne mature e lo standard al quale vengono costantemente comparate è nettamente più spietato di quello rivolto alla maggior parte degli uomini. Ma l’intenzione del film era effettivamente creare una divisione così binaria? L’unico altro utilizzatore del medicinale che vediamo nel film in fondo è un uomo, che proprio come Elisabeth, non riesce a mantenere un equilibrio sano tra le due parti di se stesso. Sicuramente la sua storia avrebbe messo in luce prospettive diverse, ma dello stesso problema. Più che altro mi chiedo quante donne possano, al di là del genere, realmente rispecchiarsi nella protagonista. Il suo totale privilegio (che resta abbastanza invariato anche nella versione sessantenne) la rende specchio di una parte minuscola della società contemporanea e sicuramente non un metro di paragone per la maggior parte di noi.
La bellezza è già di per sé una chiave che apre molte porte, in particolare nel mondo dello spettacolo. Se la si coniuga ai suoi altri agi, primo tra tutti il benessere economico, è chiaro che si sta parlando di un individuo eccezionale. Ciò non è per svalutare il dolore della protagonista, ma è per evidenziare chiaramente il più grande difetto che la contraddistingue. Non si tratta né della sua età né della sua estetica, ma della sua estrema superficialità, nel senso più letterale del termine. Non è un giudizio morale, bensì un mettere l’accento su una constatazione che sembra essere banale, ma che invece ha generato un finale sorprendentemente originale: l’apparenza estetica oltre ad essere inevitabilmente soggetta al tempo che passa, non potrà mai essere nient’altro che la parte superficiale di un essere umano, da un punto di vista organico.
L’epilogo è un tripudio di elementi visceralmente disgustosi e allo stesso tempo riesce a essere rincuorante e liberatorio. Le esplosioni e gli schizzi di sangue svincolano la protagonista dai canoni estetici e dai limiti fisici che ci siamo autoimposti in quanto società. Siamo, nel profondo, esseri fatti di carne e ossa, sangue e sostanze organiche e non di aspettative. Abbiamo forse più elementi in comune con il ketchup che vediamo spalmato sul marciapiede ad inizio film, che con i pixel di un’immagine. E come quella salsa di pomodoro, siamo biodegradabili e potremmo essere lavati via da un momento all’altro e dimenticati, proprio come succede nel film. Una realizzazione avvilente per certi versi, ma anche rassicurante.
Parlare di questo tema in un film di genere, un bodyhorror, equivale ad utilizzare l’horror come strumento che ci aiuta a mettere in prospettiva il problema: di cosa dovremmo realmente avere paura?
Elisasue comunque, con la sua mostruosità, riesce a lasciare veramente il segno nel pubblico, le sue antenate no.
Il cinema è la sostanza di se stesso
La Hollywood Walk of Fame del film diventa simbolo di una società dello spettacolo americana che sopravvive perentoriamente a tutte le ossessioni collettive che la attraversano. Così, attraverso la presenza della stella di marmo che apre e chiude il film, dedicata alla protagonista e delle numerose citazioni formali (dall’influenza di Kubrick nell’architettura dei luoghi a quella di Carrie. Lo sguardo di Satana di Brian De Palma, nella scena finale del teatro), Coralie Fargeat si prende gioco dell’iconografia del mondo del cinema, nella totale consapevolezza della sua stessa pericolosità. La tomba di Elisabeth Sparkle, cioè la stella incastonata nel cemento del marciapiede, è anche il luogo dal quale è metaforicamente nata. Perché la vita di una star a Hollywood dura il tempo del suo luccichio e dopo non ha più importanza, così come non ne aveva prima.