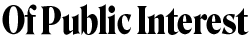Mi sono chiesta, più volte, nei mesi che hanno seguito la mia partecipazione al Festival sull’uguaglianza organizzato da OXFAM Italia, dove risiedesse la necessità di prendere un treno per Firenze e seguire dal vivo un evento a cui avrei potuto tranquillamente prendere parte online.
La risposta che mi sono data è che immergersi in un contesto in cui la priorità di coloro che parlano e che ascoltano sia la costruzione di un mondo un po’ più equo, non comporta solo un arricchimento in termini di conoscenze e scambi, determina bensì un momento di partecipazione, il punto di partenza e il punto di arrivo nella costruzione di una società civile.
Nient’altro che la strada per riappriarsi del peso delle proprie scelte in questo spazio comune dove siamo tutti, necessariamente, interconnessi.

L’ interconnessione e la complessità che caratterizza la società globale in cui viviamo è stata raccontata attraverso i dialoghi che hanno riempito le sale del Palazzo degli Innocenti e che si sono sviluppati mettendo a fuoco un unico punto: le disuguaglianze.
Questa grave patologia del nostro spazio comune si espande infatti come un veleno che attraversa gli infiniti vasi comunicanti che collegano il nostro mondo globalizzato, senza che nessun ambito o settore ne resti facilmente immune.
Ecco perchè la settorializzazione delle problematiche non può che risultare un metodo d’analisi inadatto e inefficace e per far fronte alle dilaganti ingiustize sociali diviene necessario avere una visione trasversale, come quella che ci ha consentito il festival, passando dal mercato del lavoro, all’istruzione, alla sanità fino alle guerre e ai fenomeni migratori, rivelandone le diverse forme di discriminazione ed emarginazione che ne scaturiscono.


E una volta che ci si ritrova difronte a queste dimensioni, appare chiaro che l’unica strada possibile sia quella di un’azione multiforme ed eterogenea, che consenta di mettere in gioco tutti gli strumenti necessari e iniziare a lavorare nella stessa direzione.
Non a caso Oxfam corrisponde ad un movimento: “milioni di persone che lottano contro le disuguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia.”
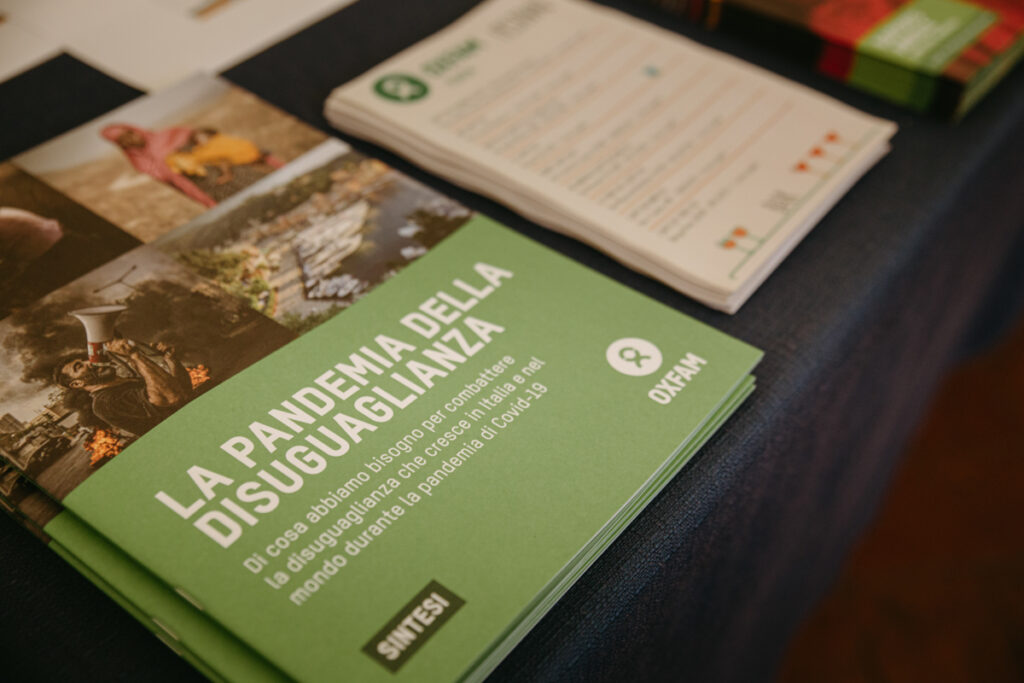

E quando ci si muove insieme, quando si inizia a partecipare, ci si ritrova difronte ad una verità semplice, spesso dimenticata: l’azione, la voce e il passo che ognuno di noi sta compiendo in quella direzione ha un valore e genererà un impatto. Ed è così che, finalmente, si inizia a scegliere.
Mi colpisce, tra le tante scelte, quella di Stefano Funari: ex manager di un gruppo svizzero decide di lasciare il lavoro per fondare un suo brand, I was a Sari.
Lavoravo per un gruppo svizzero, ben quattordici ore al giorno. Il mio lavoro era funzionale a farli arricchire ulteriormente. Poi mi sono interrogato sul senso di quello che stavo facendo. Ho lasciato il lavoro e ho fondato I was a Sari, un’azienda sostenibile, che da lavoro alle donne indiane emarginate.

I was a Sari è un brand di moda sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. Un progetto nato per dare lavoro ad un gruppo di donne indiane con l’obiettivo di renderle le designer del proprio futuro promuovendo al contempo un modello di business basato sul riciclo.
“To look good, to feel good” è l’idea che sostiene Funari ovvero che dietro al gesto semplice e leggero di indossare un capo, ci possa essere la consapevolezza profonda di aver compiuto un’azione che risponde a criteri di giustizia sociale.
E se “E’ l’economia che cambia il mondo”, come recita il titolo di un libro scritto da Gianīs Varoufakīs una decina di anni fa, allora basta guardare imprese come I was a Sari, per cominciare a credere che sia vero.


Per ridisegnare il mercato però è chiaro che non basta l’offerta, è anzi forse più determinante che si inizino a domandare se non a pretendere dei prodotti che abbiano alle spalle un ciclo di vita sano, la cui produzione non abbia impattato negativamente sulla salute dell’ambiente, degli individui o degli animali.
Non è un atto semplice quello dell’acquisto consapevole, richiede la capacità di orientarsi sulla base di informazioni e competenze che si acquisiscono nel tempo, con più attenzione e impegno di quelli che le nostre spese quotidiane consentono.
Organizzazioni come Fair Trade lavorano per questo, garantiscono che alle spalle di un prodotto ci sia una filiera strutturata nel rispetto della categoria più danneggiata: gli agricoltori. Consentire che ogni transazione sia ricompensata con il giusto guadagno, che sia imposto cioè un prezzo minimo, in territori come l’Asia, l’Africa e l’America Latina, implica non solo una realizzazione piena dei diritti del lavoro, ma anche una riduzione dei costi sociali. Gli investimenti che ne derivano in progetti nuovi, ad esempio finalizzati alla costruzione di scuole, abbattono la piaga del lavoro minorile restituendo una nuova chance alla comunità dei bambini.
La pandemia però sembra aver influito positivamente da questo punto di vista, i dati rivelano che l’attenzione dei consumatori è cresciuta negli ultimi due anni e diversi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per insistere in questa direzione come ha spiegato Giulia Comparsi, responsabile Fair Trade.
“QR Code, certificazioni, brand rinomati per sostenibilità . Sono diverse le garanzie per acquistare consapevolmente e la nostra generazione ha accesso a molte più informazioni rispetto alle precedenti. “
“Fair trade non deve esistere. Se raggiungiamo questo obiettivo il commercio sarà davvero cambiato”

Ma non c’è ambito dove non si debba lavorare sulla consapevolezza e dopo il consumo, arriva il risparmio. Oxfam ha scelto di ripartire dalle scuole proponendo un gioco interattivo che illustrasse dimensioni spesso sconosciute della finanza.
“Dove finiscono i soldi una volta che li hai depositi su un conto? Sei contro la guerra ? E la Banca dove hai depositato i soldi finanzia le armi oppure no?”
Poche domande chiare poste ad un gruppo di liceali e il risparmio ha acquisito la forma di uno strumento potente su cui diviene fondamentale esercitare un controllo per non diventare complici inconsapevoli di attività che non combacino con l’etica del nostro pensiero.
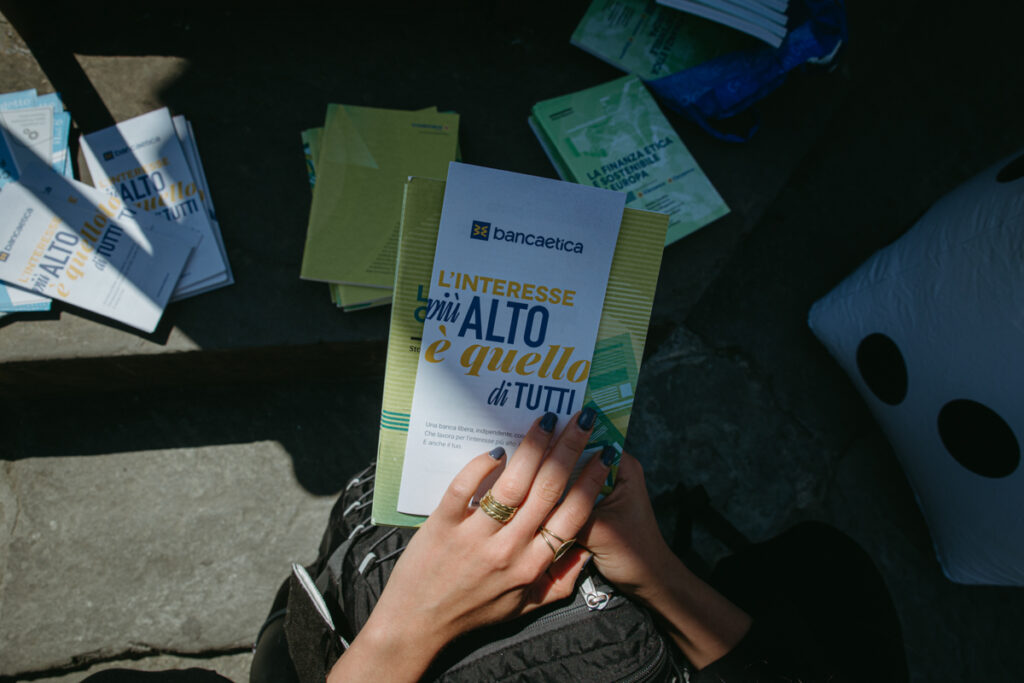







Etica e finanza, poi, non si incontrano solo nell’ambito degli investimenti, anche il credito è un tassello fondamentale nella costruzione di una società i cui strumenti finanziari siano a servizio della società.
Organizzazioni come Banca Etica lavorano quotidianamente per ampliare il più possibile l’accesso al credito, come strumento per far fronte ad emarginazione e disuguaglianze e funzionale alla lotta alla criminalità.
“Un mezzo di autodeterminazione e di empowerement” come l’ha definito Maria Francesca De Tullio, componente del comitato Banca Etica, perchè ricevere un prestito significa avere accesso ad un’ opportunità di partecipazione piena e strutturata alle dimensioni sociali.
Il credito alla stregua del lavoro è uno strumento fortemente democratico in termini di accesso ad opportunità. Come ogni strumento, acquisisce valore a seconda della modalità con cui viene utilizzato, in questa prospettiva converge parte del lavoro di Oxfam che partecipa nello studio delle policy per i lavoratori con le aziende, portando sempre un po’ più in alto gli standard da rispettare, muovendosi in funzione del living wage e non solo del minimum wage, lavorando tramite interviste ai lavoratori pronte a coglierne sempre il punto di vista.
L’aspetto più interessante del festival forse è stato proprio rilevare la capacità che ha Oxfam di dialogare con chiunque, a partire dai privati. Una strategia efficace dato che sono proprio le aziende a rivestire un ruolo fondamentale nella redistribuzione.
Oxfam infatti monitora il lavoro di diverse aziende tra cui Coop, Lavazza, Princes Industrie alimentari e il Bolton Group, che hanno presenziato al festival.

Ma se l’azione dei privati riveste un ruolo fondamentale di cui prendere sempre più coscienza, l’impatto delle decisioni delle istituzioni con le politche pubbliche è storicamente noto: “Le imprese non possono risolvere da sole inefficienze sulle quali devono agire le isituzioni” ha affermato Maura Latini, amministratrice delegata di Coop.
Una delle principali inefficienze l’ha menzionata l’ex Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: “qualunque forma di concentrazione della ricchezza e quindi di potere, non comporta mai benefici a chi non la possiede, ma, come nel caso dei territori, determina contraccolpi sul piano ambientale, in termini di diritti umani e sul piano democratico e politico. D’altro canto non c’è ingiustizia più grande del fatto che la vita e il destino di una persona siano segnate dal luogo in cui si nasce.“
Secondo Provenzano i territori sono lo specchio delle disuguaglianze, osservare le fratture sociali tra Nord e Sud, centri e periferie, città e campagne restituisce una dimensione chiara dell’ineguale accesso alle opportunità che impatta sulla vita degli individui. Gli interventi destinati a risanare questi fallimenti del mercato dovrebbero seguire l’unica logica di progresso possibile, ovvero quella condivisa. In quest’ottica, come ha affermato l’ex ministro “non c’è ingiustizia più grande del fare parti uguali tra diseguali”.
Piuttosto sono necessari grossi interventi strutturali, come quelli menzionati da Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di Oxfam International, “volti ad incidere sul modello neoliberale e a reinvestire in sanità, sicurezza, transizione sociale e adattamento al cambiamento climatico” per citare le sue parole .
Oxfam ha mostrato come iniziare con una tassazione della ricchezza, anche solo al 2% annuo per i milionari e al 5% per i miliardari potrebbe generare oltre due triliardi e mezzo di dollari ogni anno e questo è un denaro sufficiente per permettere di migliorare le condizioni di vita a 2,3 miliardi di persone e portare la sanità nei paesi a basso e medio reddito.
Ancora prima però di un’azione interventista c’è la sfera della ricerca che risulta essere determinate e canalizzante. I risultati degli studi condotti sono il frutto del pensiero di chi li mette in piedi, come spiega la docente ordinaria della Sapienza di Roma Filomena Maggino, e alla prospettiva dalla quale si osservano i fenomeni.
Le cose belle, quelle fatte bene, resistono. Una società costruita bene è una società resistente, dove i cittadini hanno fiducia nelle istituzioni e viceversa.

E per lavorare in funzione di un organismo resistente bisogna partire dalle sue fragilità: “Quando si costruisce un indicatore, questo non dovrebbe essere una misura statica, quanto piuttosto decretare in che direzione stiamo andando. Nelle analisi statistiche è necessario guardare alla complessità del sistema altrimenti spesso si rischia di perdere per la strada qualche pezzo, magari il più fragile. Ed è proprio così che si perde tutto.”
Mi sembra che la capacità di pensiero , ovvero la capacità di interrogarsi sulle dinamiche circostanti resti l’ingrediente principale in tutte le ricette per contrastare le ingiustizie sociali.
Un concetto che ha introdotto Ezio Mauro, l’ex direttore de la Repubblica, con una frase che secondo me sancisce un po’ una linea di demarcazione generale tra chi nel mondo che ci circonda sceglie di fermarsi a guardare e chi sceglie di accontentarsi e di restare nelle proprie convinzioni.
Non più tra destra e sinistra, la distinzione è tra chi pensa che la disuguaglianza sia un fatto ineluttabile e chi no.

Nelle proprie convinzioni e nei propri interessi. Quest’incapacità di guardare ciò che sembra lontano da noi, dal nostro interesse, ho sentito definirla nelle aule universitarie “una forma di miopia” dell’homo economicus. Io la chiamo piuttosto cecità emotiva, sintomo di uno scarso esercizio di empatia.
Esercitare empatia significa rilevare il mondo dell’ altro, ritrovandosi insieme in uno spazio comune perchè basato sull’incontro. Avvicinarsi permette di scoprire similitudini e di comprendere come le differenze possano ingigantirsi o rimpicciolirsi a seconda delle prospettive.
Prospettive che si costruiscono spesso sulla base di posizioni di vantaggio o svantaggio economico, educativo, di genere, fisico o culturale. Prospettive dalle quali credo sia un atto naturale quello di disegnare margini e confini.
Ecco perchè spostarsi dal punto di partenza ed entrare in contatto con l’altro diventa un esercizio fondamentale, l’unico possibile per capire che l’origine di quella discriminazione dipende dal nostro potere di disegnare confini ed è da questa prospettiva che possiamo cominciare a lavorare per abbattere quei limiti che nella realtà creano un disegno doloroso e iniquo, sporco di fame, sangue e sofferenza.