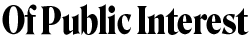Era il 26 di dicembre del 2018, di sera. A Milano si stava giocando Inter-Napoli, gara della diciottesima giornata del Campionato di Seria A. In campo i calciatori non danno vita ad una sfida dai ritmi elevati. La partita, però, è scandita da un’altra “musica”: i cori della curva milanese all’indirizzo di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, senegalese, di pelle scura. I calciatori della formazione partenopea chiedono più volte l’interruzione della partita, lo speaker del San Siro incita a più riprese lo stadio a far cessare i cori. Il tutto si risolve in un nulla di fatto.
Finirà 1 a 0 per l’Inter, complice anche l’espulsione dello stesso Koulibaly, colpevole di aver rivolto all’arbitro un applauso ironico, innervosito per la mancata interruzione della partita.
Il giorno dopo, il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo interrompe la sua attività dando vita ad una protesta a sostegno del difensore senegalese. Esce in strada armato di cartello con la scritta “Siamo tutti Koulibaly” e, soprattutto, col viso dipinto di nero.
Fu quel giorno che scoprii, con colpevole ritardo, cosa fosse una blackface.
Per comprendere di cosa si tratta e capire compiutamente tutte le implicazioni del fenomeno è necessario tornare molto indietro nel tempo.
Nel corso degli anni ’30 dell’ottocento va progressivamente codificandosi quello che è considerato il primo esempio di genere teatrale puramente statunitense, I Minstrel Show. Essenzialmente si trattava di uno spettacolo di varietà con sketch comici, danze e canzoni intepretati da attori bianchi col viso dipito di nero, a simulare la carnagione degli afroamericani. Questi “tipi fissi” del teatro ottocentesco, come tutte le maschere del resto, erano caratterizzate da una serie di tratti stereotipati fra cui la pigrizia, l’ignoranza, l’ingenuità, l’avidità e la passione per il gioco d’azzardo. Il genere ebbe un enorme successo fino ad approdare, nel corso del novecento alla TV, nel cinema e nei cartoni animati. Il contraccolpo sociale e culturale fu immenso: ancora oggi molti degli stereotipi sulla comunità nera negli Stati Uniti furono veicolati originariamente dai Minstrel Show e la blackface è diventata uno dei simboli della segregazione razziale e del razzismo nei confronti dei neri, tanto da essere proibita e censurata.
Per questo motivo (ma anche per altre questioni) Gino Sorbillo fu sommerso di insulti sui social, accuse di razzismo, minacce di morte e chi più ne ha più ne metta. Ho dimenticato la faccenda per cinque lunghi anni, fino a quando gli stessi social non mi hanno fatto esclamare la proverbiale frase “Oh shit, here we go again”.
La nostra è una città in cui qualsiasi cosa può entrare nell’epica. Sarà perché (nello sport come in altre questioni) non siamo così abituati a vincere, ma chi ci riesce diventa un eroe, un simbolo, un totem. Non poteva non succedere nell’anno in cui la squadra partenopea si appresta a vincere il suo terzo scudetto e fra gli eroi dell’impresa spicca Victor Osimhen, attaccante, nigeriano, di pelle scura, l’Achille di questo Napoli. Ecco, il calciatore è diventato un simbolo, complice anche il suo aspetto inconfondibile: stazza imponente, capelli tinti di biondo, una maschera (tutti gli eroi portano una maschera) in carbonio, la pelle scura. La città di Napoli (per business o per devozione, fate vobis) ne ha fatto quasi oggetto di culto ed ecco spuntare anche sul web le creazioni più disparate ispirate alle fattezze del nigeriano: torte al cioccolato, drink, shots, caffè con granella di noci a simularne i capelli and so on.
Un’altra nota pizzeria ha pensato bene di pubblicizzare la “Pizza Osimhen” con un breve sketch comico diffuso sui social, in cui il pizzaiolo prendeva le sembianze del calciatore: capelli tinti di giallo, maglia del Napoli, l’immancabile maschera e, chiaramente, la faccia dipinta di nero. Perfino a Carnevale sono innumerabili i video circolati sul web di piccoli Osimhen fieri del loro costume, con annessa blackface.
Osimhen è certamente il simbolo di questa nuova era per la squadra e, in una città dove il calcio è vissuto in maniera così tanto viscerale, per tutta Napoli. Ma fermiamoci un attimo a riflettere sul significato delle parole. Mi perdonerete il ricorso alla Treccani: in essa la parola “simbolo” è definita come qualunque cosa (segno, gesto, oggetto, animale, persona) la cui percezione susciti un’idea diversa dal suo immediato aspetto sensibile e la sua originaria funzione pratica è sostituita dalla funzione rappresentativa. In altre parole, un simbolo è qualcosa che nel corso del tempo si carica di un significato diverso, tanto da assumere una funzione e una valenza differente dal mero oggetto.
Prendiamo la svastica: all’apparenza è una mera croce uncinata, rappresentazione forse delle costellazioni del Piccolo e del Grande Carro, il cui centro è fissato dalla Stella Polare. Ebbene, la svastica è sin dal Neolitico un simbolo religioso per diverse culture di matrice indoeuropea e ancora oggi è visibile, fra le altre cose, sulle facciate dei templi buddhisti, a rappresentare (perdonate la semplificazione) la presenza del divino nell’ordine del mondo. E tuttavia credo che nessuno di noi, nel guardare oggi un’effige con una svastica, pensi alle costellazioni né tantomeno all’armonia dell’universo. Il Nazismo ha sovrascritto sul simbolo una serie di significati che hanno sostituito, almeno per il mondo occidentale, le sue originarie valenze religiose. La svastica non è più soltanto una croce uncinata. Essa significa la ferocia della dittatura, la follia della concezione di un’umanità divisa in razze, le atrocità dell’olocausto.
Ma, per fortuna, esistono anche simboli positivi, e Napoli da sempre è una città dove la gente vive un legame indissolubile con essi. Un grumo di sangue che (per prodigio o artificio, lascio a voi la scelta) qualche volta all’anno torna allo stato liquido, ebbene, non è soltanto un grumo di sangue. Per molti è l’emblema dell’alleanza di questo popolo con Dio, un segno di speranza, di protezione. La maschera nera di Pulcinella non è soltanto una maschera. Essa è il teatro, l’estro popolare, è il simbolo del servo che diviene più furbo del padrone, è l’arte di arrangiarsi, un mestiere che i partenopei devono conoscere perché significa saper stare al mondo. E, infine, le immagini di Maradona sui muri della città non sono solo mere rappresentazioni dell’uomo che ha fatto trionfare Napoli per la prima volta. Per la gente sono la rivalsa del sud del mondo contro il nord, degli sconfitti che qualche volta possono vincere, perché tutti abbiamo bisogno di sapere che possiamo farcela.
E così dobbiamo capire che tingersi il viso di nero non è soltanto l’atto in sé. Tingersi il viso di nero vuole anche dire segregazione razziale, mancanza di rispetto verso la comunità nera: in una parola, razzismo.
La domanda da porci adesso è: i napoletani sono consci del significato di questo simbolo? Certo, la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni, ma possiamo affermare che dietro gli omaggi certamente naif del popolo napoletano, dietro l’affetto dei bambini che emulano il loro idolo, ci sia un intento discriminatorio? Siamo tutti d’accordo nell’affermare che la blackface sia un simbolo di oppressione da censurare e condannare, ma dovremmo esserlo altrettanto nel capire che esso non è parte della nostra cultura e certamente c’è bisogno di più informazione e sensibilizzazione nei confronti del problema.
La questione è proprio questa: dietro le maschere di Carnevale dei bambini ci sono certamente degli adulti che dovrebbero essere consci che stanno mettendo addosso ai propri figli un simbolo razzista e discriminatorio. Il pizzaiolo dovrebbe sapere che la sua foto con la blackface, decontestualizzata e slegata dal tifo, potrebbe essere considerata offensiva e censurabile. Discorso un po’ diverso andrebbe fatto per il buon Sorbillo, proprietario di una catena di attività ormai internazionale, con sedi anche a New York. Possibile che nessuno dei suoi consulenti d’immagine gli abbia detto che non era un’idea proprio brillante quella di dipingersi il viso per protestare contro il razzismo? Fatto sta che l’intento della protesta era palese, e c’è un solo capo d’accusa per il quale l’imprenditore è mediaticamente imputabile: l’ignoranza della cultura americana, in cui, tuttavia, siamo tutti immersi da quasi un secolo.
Informare resta il dovere di tutti, ed è comunque più utile e umano che minacciare di morte qualcuno. Io oggi ho cercato di fare la mia parte.
Perciò, andiamo pure a celebrare lo scudetto, quando sarà, se sarà. Sono sicuro che ci ricorderemo di questa festa meravigliosa per sempre. Omaggiamo insieme Osimhen e tutti gli altri protagonisti di questa vittoria, facciamoli diventare il simbolo di una Napoli che, come al solito, parte da sfavorita ma grazie alla bellezza si mostra meravigliosa agli occhi dell’Italia e di tutta l’Europa. Perché io ci credo alla favola che lo sport e il calcio possano ispirare le nostre vite e renderci migliori, come tutte le storie che toccano le corde dell’anima. Festeggiamo, perché oggi vince il Napoli, domani potremmo vincere tutti noi.
Ma vi raccomando, niente blackface. Dipingiamoci il viso di azzurro perché, che io sappia, non esistono stereotipi razziali sui Puffi. E nemmeno sui Na’vi.