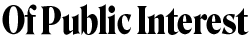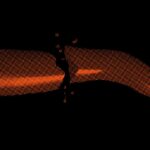Il salario minimo, secondo la nozione più accreditata, consiste nella remunerazione minima, giornaliera o mensile, che i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti.
È un istituto adottato da ben 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e, infatti, i soli ordinamenti di Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria ed Italia non prevedono alcuno strumento giuridico ad esso equiparabile.
Si tratta, seguendo una lettura accreditata, di un espediente che consente un profondo intervento pubblico nel mercato del lavoro, ed attraverso il quale lo Stato fornisce per legge uno strumento di rafforzamento del potere contrattuale in favore di soggetti potenzialmente capaci al lavoro, ma appartenenti a categorie sociali deboli, emarginate ed economicamente tormentate.
L’ingerenza del potere politico-legislativo andrebbe, insomma, a riequilibrare posizioni socialmente ed economicamente sbilanciate e permetterebbe di rimuovere, così, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà dell’individuo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Altra impostazione, di impronta liberale, sostiene che il salario minimo legale non sarebbe utile all’efficientamento del sistema. In particolare, tale lettura evidenzia che un’ingerenza tanto robusta dello Stato andrebbe ad aumentare la povertà, in quanto incrementerebbe la disoccupazione perché le imprese sarebbero restie ad assumere lavoratori non qualificati o senza esperienza ad un costo prestabilito.
I sostenitori di tale impostazione ritengono che sia più utile per l’impresa beneficiare di incentivi e sgravi fiscali-tributari e che sarebbe compito dello Stato, più che altro, garantire percorsi formativi e professionali adeguati rispetto al continuo mutamento del mercato del lavoro.
Cosa dice la Costituzione sul tema lavoro?
Dall’analisi dei principi fondamentali che governano il tema lavoro emerge che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed il riconoscimento costituzionale di tale valore è inteso come strumento essenziale e primario di sviluppo della personalità umana, ed ha come finalità il progresso materiale e spirituale dell’intera comunità. Lo Stato deve promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto ed è suo compito, tra l’altro, curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, affinché siano resi effettivi tali principi. Il fine ultimo, che innerva l’intero sistema, è la tutela della dignità umana in tutte le sue forme.
E sul salario?
Ciò posto sul piano dei principi generali, nell’art. 36 della Costituzione compare ancora una volta la bussola della dignità umana, riferita, però, alla retribuzione del lavoratore ed assume, in questo contesto, una connotazione inevitabilmente materiale. Il salario deve essere, infatti, proporzionato e sufficiente, e comunque tale da assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. In particolare, la norma stabilisce che la remunerazione dei lavoratori deve essere parametrata alla qualità ed alla quantità della prestazione lavorativa e, in ogni caso, adeguata ad evitare l’oppressione insostenibile del bisogno economico.
Il ruolo dei sindacati
Come è noto, l’ordinamento conferisce ai sindacati, in rappresentanza dei lavoratori, il ruolo chiave di stesura dei più diffusi contratti di lavoro, rapportandosi direttamente con le associazioni di categoria che rappresentano i datori di lavoro. Tali enti possono, quindi, rappresentare unitariamente i lavoratori in proporzione dei loro iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti i soggetti appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Dunque, la legge, sancendo il principio di libertà sindacale, contempla le organizzazioni sindacali come strumento di autotutela dei lavoratori e come diritto politico in quanto, attraverso i sindacati, i lavoratori partecipano alla determinazione delle linee di politica economica e sociale del paese.
Nella determinazione dei contratti collettivi nazionali, i sindacati provvedono, in particolare, alla definizione dei salari, prevedendo specifiche categorie professionali, che tengano debitamente conto delle qualifiche, delle mansioni e delle competenze specifiche dei singoli lavoratori. L’ordinamento attribuisce, dunque, alle organizzazioni sindacali una posizione delicata, incaricandoli non solo di tutelare i diritti dei lavoratori ma anche di fissare, nella fase della contrattazione, le retribuzioni dei dipendenti, tenendo soprattutto conto delle indicazioni costituzionali.
Il caso
Una recente controversia, posta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), ha riaperto, anche mediaticamente, il dibattito circa la necessità di introdurre per legge il salario minimo.
La questione trae origine dalla richiesta di alcuni lavoratori, con mansioni di portieri e guardiani notturni, che lamentavano di ricevere retribuzioni eccessivamente basse ed il cui valore si collocava addirittura al limite della soglia di povertà, nonostante tali salari fossero previsti dai minimi tabellari del contratto collettivo. In particolare, la retribuzione di tali lavoratori era pari, al netto mensile, ad € 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria di € 5,49, senza maggiorazione, peraltro, per il lavoro notturno. Sul piano della sufficienza, la retribuzione si assestava appena sopra la soglia di povertà, che, secondo il rapporto ISTAT per l’anno 2018, per un residente in un’area metropolitana del nord Italia, e di età compresa tra i 18 ed i 59 anni, era pari ad € 834,66 mensili, e che aumentava ad oltre € 1.600,00 nel caso di moglie e figli a carico.
Secondo una lettura tradizionale, mai abbracciata pienamente dalla giurisprudenza, i minimi salariali tabellari dei contratti collettivi, integrerebbero presuntivamente il parametro costituzionale della retribuzione sufficiente e proporzionata, ai sensi dell’art. 36 Cost. I minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, dunque, sarebbero assistiti da una presunzione assoluta di adeguatezza al principio di proporzionalità ed equità della retribuzione.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha, invece, statuito che “in sede di applicazione dell’art. 36 Cost. il giudice di merito gode (…) di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattuali-collettivi (sia in concorso, sia in attuazione) con l’unico obbligo di dare puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.”.
Il Giudice può, quindi, “utilizzare anche parametri differenti da quelli contrattuali e fondare la pronuncia (anche) sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi anche su criteri equitativi”. La sentenza chiarisce, insomma, che la Costituzione non si limita a stabilire se sia dovuto o meno un salario proporzionato e sufficiente, ma attribuisce a chi lavora il diritto ad una retribuzione con contenuti qualificanti che si riferiscono, in particolare, al quantum del corrispettivo.
Dunque, “nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione”. Pertanto, i criteri stabiliti nella Costituzione sono gerarchicamente sovraordinati alla legge ed alla stessa contrattazione collettiva poiché attinenti ad un valore fondamentale della persona umana: la dignità.
Come si stabilisce l’equità?
Si chiarisce, così, che l’equità del minimo salariale previsto dal contratto collettivo nazionale può essere valutata in concreto dal giudice, al di là della previsione contrattuale. Il giudice deve tener conto della retribuzione netta e non lorda, poiché il tenore di vita è valutabile solo con riferimento alla somma effettivamente spendibile dal lavoratore. Inoltre, il giudice può, nella comparazione, tener conto anche di altri contratti collettivi che disciplinano le medesime mansioni, ma in settori differenti. Ancora, la valutazione deve far riferimento anche alla soglia di povertà calcolata dall’ISTAT. La sentenza conferma, quindi, che il giudice può, in spregio a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, discostarsi dai minimi tabellari (sia in aumento che in diminuzione) ed individuare in autonomia, secondo i parametri citati, una retribuzione che sia per il lavoratore che chiede tutela proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), imponendola alle parti. Si evince, dunque, che in assenza di intervento da parte del legislatore, il giudice è chiamato a dare piena attuazione alle norme della Carta costituzionale.
Per dirsi equa e conforme a Costituzione, la retribuzione non deve garantire la mera sopravvivenza, ma deve consentire al lavoratore un tenore di vita tale da permettergli di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del proprio paese. Una parte, non meno significativa, del salario deve consentire all’individuo di acquistare un libro, andare al cinema o al teatro, ascoltare un concerto. È questo il senso della pronuncia in commento che, oltre a stimolare un dibattito già vivace dal punto di vista sociale e politico, sembra, in qualche modo, suggerire al legislatore un intervento, che possa dare effettività al volere della Costituzione. Un salario non adeguato, non riconducibile al parametro della sufficienza, potrebbe minare nel profondo la tenuta sociale del paese non consentendo la coesione ed il progresso della comunità. È, d’altronde, vero che è compito della Repubblica curare la formazione e la crescita dei lavoratori, adeguando i percorsi professionali al continuo divenire del mercato del lavoro rafforzando, così, il loro potere contrattuale.